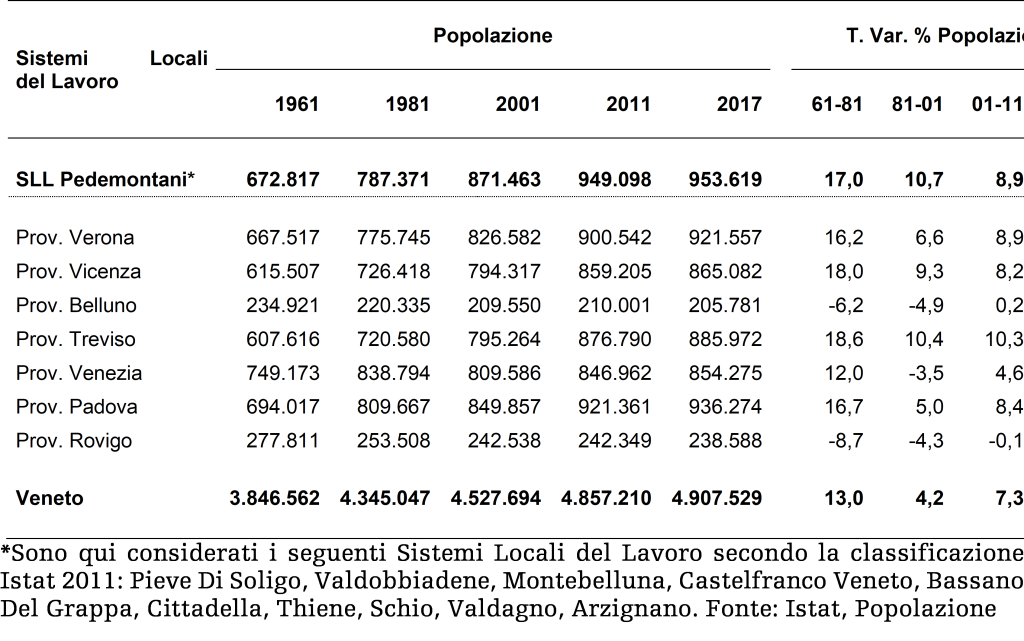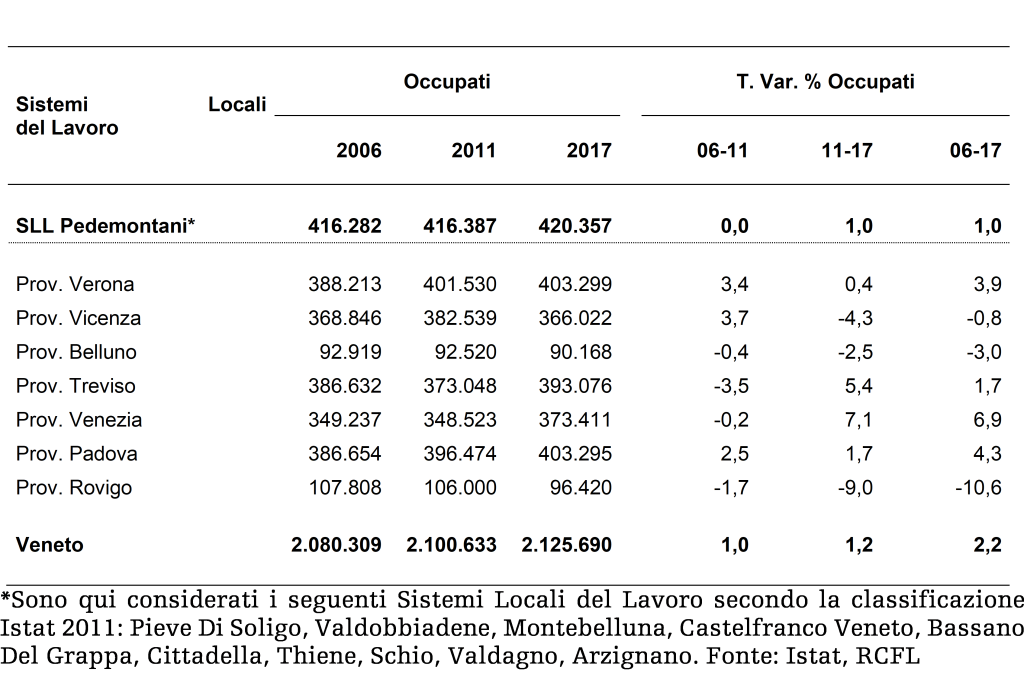[di Luca Pavan]
I problemi legati alla scarsità delle risorse idriche sono rimasti a lungo al di fuori del dibattito pubblico del nostro Paese. La situazione sta tuttavia rapidamente cambiando negli ultimi anni. Se tematiche di questo tipo venivano relegate, almeno nell’immaginario collettivo, a latitudini del mondo decisamente più a sud, ora non sembra più esser così. Non solo le testate giornalistiche italiane, ma anche vari report di istituzioni internazionali, dipingono un quadro sempre più critico, legato soprattutto al riscaldamento climatico. Le Nazioni Unite mostrano che l’indicatore di water stress, ovvero il rapporto tra i prelievi di acqua rispetto alla quantità di risorsa rinnovabile, è critico non solo nelle zone del mondo prima citate, ma anche nella maggior parte dei paesi dell’Europa meridionale, Italia compresa. In aggiunta, gli studi del World Weather Attribution dimostrano come le ondate di calore registrate in Europa negli ultimi anni siano conseguenze del cambiamento climatico. Se ne desume quindi che questi fenomeni non siano probabilmente da considerarsi come un’eccezione, una singolarità, ma come eventi che sempre più influenzeranno le nostre società.
Non è solo un problema di tipo climatico.
Secondo un recente report di Istat, l’Italia risulta essere il terzo paese europeo per prelievi di acqua dolce per uso potabile pro capite, con 155 metri cubi annui. Questo alto valore è da attribuire in parte anche all’inefficienza della rete di distribuzione: nel 2022 il volume delle perdite idriche totali ammonta a 3,4 miliardi di metri cubi, ovvero il 42,4% dell’acqua immessa in rete. In altri termini, la quantità che viene persa nel sistema sarebbe sufficiente a soddisfare le esigenze idriche di altri 43,4 milioni di persone per un interno anno.
Istat cita anche le causa di un tale livello di perdite: oltre ai fattori fisiologici – non esiste un sistema a perdite zero – vengono menzionate le rotture nelle condotte, la vetustà degli impianti, errori di misura dei contatori e usi non autorizzati. Anche in questo caso però, il tasso di dispersione non è uguale in tutte le regioni, e traccia una divisione tra le regioni del Centro-Nord e quelle del Sud. Quest’ultime si ritrovano tutte al di sopra del dato nazionale in termini di perdite, con i valori più alti in Basilicata (65,5%), Abruzzo (62,5%), Molise (53,9%), Sardegna (52,8%) e Sicilia (51,6%).
Gli acquedotti in Italia si sviluppano per circa 500mila chilometri. Di questi, il 60% è stato installato oltre 30 anni fa e il 25% supera i 50 anni. D’altro canto, il tasso nazionale di rinnovo è pari a 3,8 metri di condotte per ogni chilometro di rete: a questo ritmo sarebbero necessari 250 anni per sostituire l’intera rete (fonte FAI).
Dal problema alla soluzione: un passo tutt’altro che breve
Se la problematica sembra quindi facilmente ascrivibile all’inefficienza della rete, non altrettanto facile risulta essere la soluzione.Si stima infatti che l’investimento per adeguare e mantenere la rete idrica nazionale ammonti a circa 5 miliardi all’anno, risorse che attualmente non sono alla portata delle finanze italiane (fonte Utilitalia). Difatti, se in media i paesi europei spendono 82 euro per abitante l’anno in investimenti da parte dei gestori, il livello italiano si ferma a 38 (dati riferiti al 2021, fonte Utilitalia). Questi dati sottolineano da un lato l’importanza che rivestono gli investimenti nell’efficientamento della rete, dall’altro la difficoltà nel reperire le risorse per attuarli. Questo mismatch è indicatore del fatto che il problema legato alla dispersione idrica non sarà facilmente risolvibile nell’immediato futuro, nonostante le risorse messe in campo attraverso dei piani europei (React-Eu) e il PNRR, divise in 4 linee di intervento:
- Infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico;
- Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua;
- Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche;
- Investimenti in fognatura e depurazione.
Gli eventi siccitosi e le conseguenti criticità legate alla fornitura di acqua alla popolazione, intensificatesi negli ultimi anni, dimostrano come ormai la situazione non possa più essere ricompresa nel termine “emergenza”, nel senso di circostanza imprevista, che porta tutt’al più a soluzioni temporanee e sicuramente non ideali per la popolazione. Ne sono un esempio le recenti misure di razionamento imposte in alcune regioni del Mezzogiorno piuttosto che la grave siccità che ha colpito il fiume Po nel 2022.
Guardare all’esperienze di altre regioni del mondo può avere senso?
E’ opportuno chiedersi se non ci siano lezioni o moniti di cui tenere traccia dai Paesi che già hanno dovuto fronteggiare gravi carenze idriche. Ne sono esempio alcuni paesi del Sud del mondo, come quelli dell’Africa Sub-Sahariana. Quest’ultima è una delle zone in cui si registrano i più alti tassi di crescita della popolazione. Quest’aumento va di pari passo con quello della componente urbana, che negli ultimi trent’anni ha dato una forte spinta alla nascita di diverse metropoli, in cui oggigiorno convivono, a pochi chilometri di distanza, ambasciate ed insediamenti informali. Proprio quest’ultimi sono il simbolo di una pianificazione urbana e infrastrutturale che non ha mantenuto il passo della crescita demografica.
Esempio lampante di queste trasformazioni è Nairobi, capitale del Kenya. Ad oggi, la disponibilità idrica della città riesce a soddisfare solo circa il 64% della propria domanda. Nel 2009 sono quindi partiti i primi studi di fattibilità su un progetto per raccogliere più acqua dai fiumi che scorrono a nord della città, in modo da poter stare al passo con la domanda dei prossimi decenni. Tale progetto è un esempio di strategia di gestione delle risorse idriche basata sul lato dell’offerta, che appunto prevede lo sfruttamento di nuove fonti ancora vergini per far fronte al fabbisogno cittadino. Tuttavia, la letteratura è ormai critica nei confronti di questa visione, non sostenibile nel lungo periodo, specialmente in un contesto come il Kenya, dove l’esponenziale crescita della popolazione urbana e gli effetti del riscaldamento climatico stanno mettendo a dura prova le già scarse risorse idriche del Paese.
L’azienda responsabile della distribuzione idrica per la città, la Nairobi City Water and Sewerage Company (NCWSC) ha adottato un programma di razionamento, in modo da poter raggiungere i cittadini della capitale in modo più equo. Nonostante ciò, determinate parti della città e fasce della popolazione rimangono spesso non servite. La scarsità della risorsa fa sì che i singoli utenti competano per quest’ultima con investimenti propri: installazione di pompe elettriche, cisterne, fonti alternative quali il traforo di pozzi privati e la distribuzione tramite autocisterne, sempre private. L’adozione di questi sistemi dipende però dalla disponibilità economica dell’utenza. La distribuzione torna, quindi, ad essere diseguale, nonostante i tentativi delle autorità di servire ogni cittadino di Nairobi. Ne è testimone il fatto che nei quartieri più abbienti della città vi è un consumo che varia dai 200 ai 300 litri a persona, mentre negli insediamenti informali si aggira intorno ai 20 litri.
Fortunatamente in Italia le problematiche hanno al giorno d’oggi una magnitudo diversa da quella kenyota. Vi sono meno disparità economiche, una maggiore presenza delle istituzioni e una rete idrica già strutturata, solo per citare alcune differenze. Detto ciò, la situazione nella capitale kenyota è una chiara dimostrazione delle conseguenze che possono emergere nel caso in cui il fenomeno non venisse efficacemente fronteggiato dalle amministrazioni.
Ora, dato che le soluzioni di tipo infrastrutturale richiedono ingenti investimenti e tempi lunghi, è possibile immaginare che situazioni di criticità emergeranno anche in futuro. Com’è possibile quindi affrontare la problematica con soluzioni economiche con un impatto a breve termine?
Rimanendo nel Sud del mondo, è emblematico il caso di Città del Capo. Tra il 2015 e il 2018 la grave siccità ha più volte minacciato la città di 4,6 milioni di abitanti con il Day Zero, ovvero il taglio completo della fornitura idrica. Questo evento è stato evitato attraverso una costante campagna di informazione da parte delle autorità, mirante a ridurre i consumi da parte dei propri cittadini. Per quanto estremo, questo esempio ci dà due suggerimenti. Il primo: attraverso un approccio comunitario è possibile raggiungere in modo molto più efficace determinati obiettivi. Il secondo: la gestione del comportamento delle persone può avere effetti tangibili. Difatti, il caso rientra nelle misure che vengono definite in letteratura demand-driven, ovvero di gestione della risorsa idrica attraverso un suo consumo più efficiente. Delle politiche pubbliche cosiddette comportamentali, possono essere un prezioso strumento per questo fine. Questo approccio si basa sul capire quali sono i fattori che portano ad un consumo non efficiente e a creare delle politiche che agiscano su di essi.
In conclusione, è chiaro quindi che l’acqua non possa più essere trattata come una risorsa illimitata, sia dalla popolazione che dalle istituzioni. D’altro canto, nei periodi in cui le quantità disponibili si riducono drasticamente, come si osserva sempre più spesso, non è né sostenibile né efficiente una gestione emergenziale o peggio ancora lasciata ai singoli cittadini. Viste le difficoltà tecniche ed economiche sopra citate, vi è bisogno di un approccio che diventi quanto più possibile strategico, che non si limiti ad un singolo intervento “calato dall’alto” ma che coinvolga più attori e più soluzioni. In primis, deve però esserci la presa di coscienza del problema e della sua portata, nonché la volontà di affrontarlo e non di essere in balia di quest’ultimo.